La grazia di non sposarsi
La nota è molto lunga, quindi la dividerò in due parti.
——————————–
Innanzitutto va detto con franchezza che il celibato è in se stesso dottrina ecclesiastica e non viene direttamente dalla Rivelazione, sebbene infatti sia Paolo che Gesù lo raccomandino tuttavia non si sono mai sognati di renderlo obbligatorio per chicchessia, questo però significa che fin dall’inizio della storia della Chiesa ci sono stati uomini e donne che hanno scelto la “verginità per il Regno”. All’incirca intorno all’anno 1000 la Chiesa ha cominciato a scegliere i suoi preti solo tra coloro che avevano questa vocazione alla verginità. Il Concilio di Trento ha poi reso irreversibile questa scelta, facendone una legge ecclesiastica.
Si deve notare quindi innanzitutto che è improprio dire che la Chiesa impone il celibato ai sacerdoti, quanto piuttosto che li sceglie tra coloro che sono chiamati al celibato. Non è una questione di lana caprina, ma una differenza di impostazione sostanziale, ovvero: il dono della verginità (perché di un dono si tratta come vedremo tra poco) precede quello del sacerdozio e ne è in certo modo un presupposto. Uno dei motivi per cui l’aspirante passa 5 o 6 anni in seminario prima di essere ordinato è proprio per verificare se ha effettivamente questo dono.
Dunque la verginità è un dono, è un dono perché è soprannaturale. È infatti al di là della natura astenersi non solo dall’esercizio della sessualità ma soprattutto dalla generazione (vi assicuro che superate le tempeste ormonali della giovinezza questo secondo aspetto pesa assai di più) e conservarsi equilibrati e sereni nei propri rapporti umani, tuttavia non deve scandalizzare il fatto che la Chiesa domandi a quelli che devono ufficialmente rappresentarla di vivere al di sopra della natura umana, non siamo forse tutti chiamati a trascendere la nostra natura, ad essere “più che umani” in un certo senso? Non è pieno il Vangelo di esigenze che vanno al di là della natura (dal perdono delle offese, all’amore al nemico al non cercare il proprio interesse)?
Ma soprattutto la verginità è un dono per ciò che produce nell’animo di chi la esercita. Premetto innanzitutto che non è da intendere in senso soltanto fisico, esiste una verginità del cuore di cui la verginità fisica è il presupposto, ma che di questa è la vera sostanza, per capirci non vivrebbe la verginità colui che pur astenendosi dal contatto fisico si consumasse di desiderio. Ora questa verginità del cuore produce nell’animo di chi la vive una libertà sorprendente (che i santi chiamano “la santa indifferenza”) una capacità cioè di trascendere i propri desideri, di liberarsi di essi, per guardare solo all’oggettivo, a ciò che è, di concentrarsi interamente ed esclusivamente sulla propria missione. Essere vergini significa esistere solo per la propria vocazione, diventando così affilati come una lama, precisi come un rasoio, attenti ad una cosa sola. Per dirla con le parole di Von Balthasar, vergine è colui nel quale “funzione ed essenza coincidono”.
Ma c’è di più di questo, la verginità infatti consente un rapporto con Dio infinitamente intimo. Il vergine percepisce Dio come il suo sposo/a e trae dall’intimità con Lui quella pienezza affettiva che si è negato con il matrimonio. Questo non vuol dire ovviamente che gli sposati non possono pregare, ma solo che la natura del rapporto con Dio è differente.
Evidentemente un dono simile non è gratuito, nel senso che il sacerdote nella sua vita lo paga e a caro prezzo, il sacerdote più del religioso, perché i conventi offrono una serie di strutture e regole che hanno precisamente la funzione di aiutare a vivere la vocazione alla verginità. Il prezzo che paghiamo è quello di una sofferenza continua, è un po’ come avere una ferita sempre aperta, una solitudine che morde specialmente nei momenti difficili della vita (un lutto, una malattia) quando è più naturale sentire il desiderio di una persona accanto, ma anche la sera prima di andare a dormire o la mattina al risveglio e tuttavia l’esperienza che facciamo è che questa sofferenza è continuamente mutata in tenerezza. Dalla ferita che ci scava il cuore scaturisce una fonte, se abbiamo il coraggio di non richiuderla e di non farla cicatrizzare.
Proprio perché conosco bene questa fatica e questa sofferenza non mi permetterò mai di giudicare o condannare chi non ce la fa, i sacerdoti che cedono hanno tutta la mia comprensione e il mio affetto e tuttavia questo non può portarmi a negare gli immensi benefici che dalla pratica del celibato ecclesiastico derivano sia alla vita del prete (come già detto) sia alla vita della Chiesa. Non sono pochi infatti quelli che si chiedono se questo prezzo non sia troppo alto (più tra i laici che tra i sacerdoti in verità) e se non ne siano venute meno le ragioni storiche. A questo proposito vorrei quindi far notare la convenienza del celibato, non solo per le motivazioni spirituali che ho già portato ma anche per una serie di considerazioni pastorali e pratiche.
Innanzitutto penso che il celibato è particolarmente opportuno proprio in un tempo come questo, dove il sesso sembra essere diventato una forza così onnipervasiva e totalizzante da essere quasi divinizzato, dove la pubblicità vorrebbe farci vivere in uno stato di continua eccitazione, quasi che dovessimo avere una erezione permanente, dove i vizi più o meno pubblici vengono giustificati con un’alzata di spalle dicendo “in fondo è umano”, è fondamentale che ci siano uomini e donne che invece hanno il coraggio di testimoniare con la propria vita che il sesso non è tutto, che si può rimanere persone equilibrate e serene anche nell’astinenza. E’ una vera funzione profetica, un attacco diretto al più grande idolo del nostro tempo (Priapo più che Venere). Credo quindi che sarebbe un gravissimo errore da parte della Chiesa “abbassare il prezzo” e rinunciare a questa profezia.
Molte volte sento dire che per evitare il rischio di coinvolgersi in certi scandali e situazioni grottesche (pedofilia etc.) Sarebbe bene che i preti si sposassero. Ora, a parte il fatto che le statistiche sulla pedofilia confermano che non c’è affatto un’incidenza maggiore di questo vizio nei preti rispetto ad altre categorie che pure si occupano di bambini (insegnanti, allenatori etc.), io non credo affatto che la soluzione di un problema personale possa essere l’abbassamento del proprio obiettivo esistenziale, è cattiva psicologia questa. Del resto le statistiche sui pastori protestanti (che vengono spesso portati ad esempio in questa discussione) provano che il matrimonio non diminuisce affatto le tensioni a cui un pastore è sottoposto, anzi, semmai ne pongono di nuove e diverse, ho amici pastori che tutto sommato mi invidiano la mia condizione di celibe. Lo sapevate che il 40% dei pastori protestanti divorziano? Ve lo immaginate che cosa potrebbe succedere se accadesse la stessa cosa nella Chiesa cattolica?
Si sente altresì dire che se venisse tolto l’obbligo del celibato avremmo più vocazioni, ammesso e non concesso, io non credo che il problema maggiore della Chiesa sia la scarsità dei sacerdoti, sono pochi è vero, ma per risolvere questo problema basterebbe ridisegnarne il ruolo e la funzione. Non credo che abbiamo bisogno di più preti, ma semmai di preti più santi.
Da ultimo una piccola considerazione su come vivere oggi questo dono. È chiaro che un prete in parrocchia non può isolarsi dal mondo femminile, non può per la sua missione (almeno il 70% delle persone che frequentano ordinariamente le nostre chiese sono donne) e soprattutto sarebbe anzi controproducente, finirebbe con l’innescare in lui quella morbosità del desiderio che come ho detto sopra è lontana dalla verginità quanto la satiriasi.
Al contrario io penso che sia importantissimo per vivere in maniera equilibrata il celibato (almeno per noi che viviamo in parrocchia e quindi nel mondo), avere buone amicizie femminili, ricordo la sorpresa di una webamica quando alcuni mesi fa proponendole di incontrarci personalmente l’ho invitata a cena, era così sbalordita che mi fece sorridere, evidentemente come donna non poteva immaginare di avere un rapporto normale con un prete, si chiedeva perfino se mi fosse possibile…
Il celibato per noi preti secolari quindi non consisterà nel chiudersi in una impenetrabile torre d’avorio senza comunicare a nessuno la nostra affettività, ma al contrario in una verginità del cuore che ci permette di rischiarci ogni giorno nei rapporti umani, di “abbracciare senza voler tenere” le donne che incontriamo.
Sì, il celibato non è per persone anaffettive, per i polli freddi, ma per uomini e donne che sanno amare davvero e tuttavia avendo rinunciato a se stessi vivono in un dono continuo.
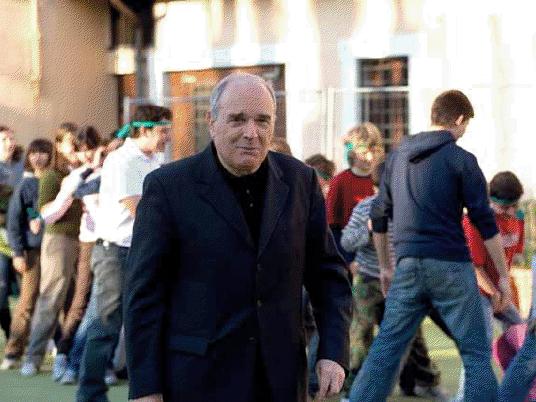
Parlando del celibato mi sono trovato inevitabilmente a parlare della solitudine, perché le due cose sono inestricabilmente intrecciate. Però quello della solitudine è un tema importante, che merita una trattazione a parte, anche perché apre la porta a molte altre considerazioni perché in fondo quello del celibato è un caso particolare di una dimensione più vasta che è quella del rapporto del prete con il mondo.
Innanzitutto distinguiamo, c’è solitudine e solitudine, l’inglese ha due parole diverse per indicare due diverse forme di solitudine, la loneliness, e la solitude, che potremmo forse tradurre, con un brutto neologismo, “solitarietà”. È diverso infatti essere soli o essere solitari, la prima condizione è subita, la seconda è una scelta, la prima è un peso a volte insopportabile, la seconda è un indispensabile rientrare in se stessi per riscoprire in Dio le ragioni delle proprie scelte e la intima forza che ci guida.
Ora, mentre il monaco ha per vocazione la solitudine (la parola monacus significa appunto solitario), tanto da dire con S. Bernardo “O beata solitudo, o sola beatitudo”, il prete al contrario è uomo per gli altri, il suo scopo è quindi essere in mezzo agli uomini, non per nulla “parrocchia” viene dal greco parà oikia (vicino alle case), egli certamente deve conoscere la “beata solitudo” di Bernardo, ma non potrebbe mai dire che è la sua “sola beatitudo”.
Ora, guardando a tanti miei confratelli devo dire sinceramente che spesso questa tensione tra loneliness e solitude in molti di noi resta irrisolta, vedo tanti preti che sembrano incapaci di stare in mezzo alla gente, quasi che abbiano paura di contaminare la loro solitude.
Ci sono anche ragioni storiche per questo, quando il Concilio di Trento istituì i seminari per rimediare alla drammatica carenza di formazione del clero l’unica spiritualità disponibile era quella monastica, e così per secoli i preti si sono formati studiando testi nati in ambiente monastico e scritti per i monaci; è chiaro che insieme ad un immenso amore per Dio da essi hanno imparato il disprezzo del mondo e di tutto ciò che è terreno, cosa che va benissimo per un monaco, ma difficilmente è conciliabile con la vita di chi ha scelto di essere parà oikia.
Non poteva essere diverso prima del Vaticano II, perché non esisteva una spiritualità “secolare”, non era ancora entrata nella “mens ecclesiae” l’idea che il mondo non fosse cattivo di per sé, ma potesse essere un luogo di santità. Ma oggi, avendo visto l’esperienza degli istituti secolari e dei movimenti, non potrebbe essere possibile ripensare tutto il nostro rapporto con ciò che chiamiamo “mondo”? Non potrebbero essere Charles de Foucauld e Lazzati, Chiara Lubich e Kiko Arguello, Escrivà e don Giussani, i riferimenti formativi nei seminari, più che S. Teresa e S. Giovanni della Croce? Non voglio dire che i classici andrebbero abbandonati, certamente non come riferimento ideale e tensione profonda, voglio solo dire che le modalità di una spiritualità monastica sono di fatto impossibili a chi vive nel mondo, come un prete in parrocchia. Il palpabile disagio dei religiosi che fanno vita in parrocchia, costretti spesso a scegliere tra la fedeltà alla regola e la fedeltà al ministero, è un buon segno di questo.
Penso soprattutto al primo paragrafo della GS quando dice “Nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel cuore dei discepoli (di Cristo)”. Penso alla memorabile allocuzione di Paolo VI a conclusione della quarta sessione. Penso a Gesù, sommo sacerdote, scelto tra gli uomini per il bene degli uomini nelle cose di Dio. Penso al Padre, che ha tanto amato il mondo da dare il suo unico Figlio. Questo amore per il mondo è il vero fondamento del sacerdozio secolare.
Troppo spesso noi stiamo di fronte al mondo con paura anziché con speranza, il mondo è pericoloso in verità solo per chi porta con sé il pericolo, per chi, non avendo risolto le sue tensioni interiori, i suoi conflitti di identità, al confrontarsi con la realtà vede andare in pezzi le sue certezze, ma la risposta a questa fragilità non può certo essere la fuga o l’isolamento.
A restare in superficie del resto il mondo può apparire arido e freddo e generalmente lo è per tutti, credenti o no, difficilmente esso si presenta come un luogo ospitale in sé e quindi la tentazione della fuga mundi oggi conosce forme più aggiornate, a volte anche le nostre comunità o i nostri movimenti possono essere isole serene in cui cercare riparo dalla durezza del mondo, così come un certo tradizionalismo anacronistico.
Invece il campo è il mondo (Mt. 13,38), è il campo in cui è nascosto il tesoro del Regno, in cui cresce con la zizannia anche il buon grano, se quindi accettiamo di fare la fatica di non fermarci alla dura scorza delle esperienze quotidiane, se accettiamo la provocazione di scendere nelle profondità delle cose allora troveremo il tesoro prezioso. Sì, tutto è riflesso del Verbo, non c’è atto autenticamente umano che possa prescindere dall’essere l’uomo immagine e somiglianza di Dio, non c’è quindi atto autenticamente umano che non sia in qualche modo divino.
Si tratta di vivere ogni rapporto, ogni incontro, ogni relazione riconducendola alla radice, riportare ogni cosa e persona allo sguardo di amore del Creatore che guardandola uscire dalle sue mani ha detto: “è cosa buona”.
Quanto ha bisogno di questo il nostro tempo! Quanto ha bisogno ad esempio di sentirsi dire che il corpo è cosa buona, che in ogni uomo e in ogni donna giace un valore infinito, che la sessualità non è una cosa sporca ed egoista in sé. Noi viviamo in una cultura che vorrebbe insegnarci che tutto è sporco, la politica, l’economia, il sesso, la vita, l’amicizia…. “Tutto è impuro” è il grande grido che attraversa il mondo, grido di dolore nei deboli, nei semplici, soprattutto in tanti giovani che ho incontrato e accompagnato nei primi passi di vita nello Spirito, grido di guerra invece per tanti astuti mercanti che vogliono servirsi di questa impurità per estirpare dal cuore dell’uomo il sogno della nobiltà e della grandezza a cui è destinato. Se tutto è impuro allora tutto ha un prezzo, tutto può essere comprato e venduto, ma quindi più nulla ha valore in sé, se non per l’utile che ne ricavo, nulla è più degno in sé, e tutto diventa grigia ed indistinta merce.
Ecco allora la sfida di una spiritualità secolare, riconsacrare il mondo, non come se si aggiungesse al mondo qualcosa dall’esterno, ma piuttosto riscoprendone la intima e propria bellezza, restituendo a tutto ciò che è umano la dignità perduta. La sfida di una spiritualità secolare sta nel dire che non c’è nulla di profano in sé, ma tutto è consacrabile. Attenzione non “tutto è sacro”, dire questo di fronte ai tanti orrori di cui è capace l’uomo sarebbe follia, ma “tutto è consacrabile”, ovvero tutto è riconducibile alla sua fonte originaria, all’Amore Creatore che vuole e sostiene ogni cosa.
Di fatto, a partire dai tre voti, tutta la spiritualità sacerdotale va ripensata radicalmente per chi vive in parrocchia. Come potrebbe vivere un’obbedienza in stile monastico un parroco che nel migliore dei casi riesce a parlare con il suo vescovo due volte in un anno? È chiaro che nel suo caso l’obbedienza dovrà assumere la forma di una intelligente corresponsabilità.
E non è del tutto evidente che va profondamente ripensato lo stile del celibato? Certamente un parroco non può vivere il suo celibato nell’isolamento, né è pensabile che possa non rapportarsi in modo anche affettivo con tutte le donne che incontra. Come osserva Giovanni Paolo II nella lettera ai sacerdoti del Giovedì santo 1995 una serena ed equilibrata amicizia femminile è probabilmente il miglior aiuto alla vita celibataria.
E infine la povertà. Certamente il parroco deve per ragioni d’ufficio maneggiare denaro ed anche possedere personalmente taluni beni, spesso utilissimi per il ministero. Quanto sarebbe più utile insegnare ai seminaristi le basi di un’amministrazione semplice e sobria, piuttosto che riempirgli la testa di ideali inapplicabili, che poi, proprio perché troppo elevati, vengono subito abbandonati! Questo del rapporto con il denaro mi sembra essere il punto più dolente della nostra formazione. A volte vedo che i nostri preti vivono una sorta di sorprendente schizofrenia. Non di rado accade di vedere sacerdoti anche di grande spiritualità e santità personale che quando si tratta di maneggiare denaro diventano (magari in nome di un fine santo) di un cinismo sorprendente e manifestano una disinvoltura che non di rado sfiora l’immoralità e l’illegalità.
L’ultimo punto fondamentale mi sembra essere quello del linguaggio. Un amico missionario mi diceva tempo fa che prima di poter annunciare il Vangelo occorrono anni per imparare la mentalità, la lingua, la cultura della gente del posto dove si vive. E non sarà la stessa cosa anche per noi? Anche questa è incarnazione.
Anche nella Chiesa sembriamo a volte parlare un linguaggio che alla maggior parte delle persone risulta incomprensibile. Ci capiamo tra noi e ci battiamo le mani da soli, ma chi vive nel mondo giudica i nostri discorsi o come eterei sogni e utopie o semplicemente se ne disinteressa. Raramente riusciamo ad essere davvero incisivi e quando lo siamo, di solito lo siamo su un livello solo sentimentale, che non ha il potere di incidere davvero sulla realtà.
Del resto credo che sia al pastore che spetta il compito di capire il gregge e di cercarlo e non viceversa.
Ricordo l’allocuzione di chiusura del Concilio, quando Paolo VI ha parlato della simpatia con cui il Concilio aveva guardato il mondo. Questa simpatia è ciò di cui più di tutto abbiamo bisogno, perché certo non potremo capire il linguaggio del mondo se non partiamo innanzitutto dalla stima per esso e per le persone che in esso vivono.
Per imparare il linguaggio del mondo i preti hanno bisogno di vivere l’amicizia con i laici, ecco perché guardo con una certa diffidenza i tentativi di superare la solitudine dei sacerdoti creando associazioni sacerdotali o spingendo i presbiteri ad incontrarsi tra loro, come avviene nei corsi di formazione permanente organizzati dal Vicariato (che del resto già la PO auspicava), non che siano cose cattive in sé, ma mi pare che non risolvono il problema e che rischiano ancora una volta di creare una mentalità da casta.
Mi pare molto più utile e sano che il prete viva le sue amicizie serenamente con il mondo laicale, magari con due o tre coppie sposate, che potrebbero aiutarlo molto di più a comprendere cosa è la vita in famiglia e nel mondo del lavoro di tanti trattati e incontri di pastorale.
dopo aver parlato della loneliness manca ancora una terza parte in cui parlare della solitude, datemi un po’ di tempo…

Nessun commento:
Posta un commento